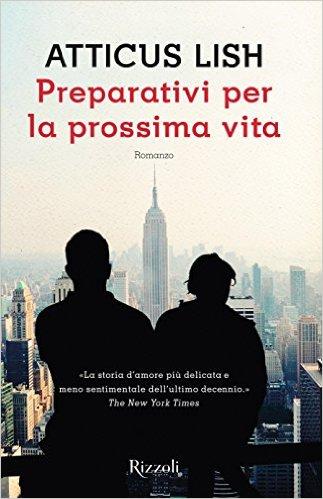L’autore, un giornalista Apticus Lish, poco più che quarantenne, figlio di Gordon Lish mitico editor di Raymond Carver, ha insegnato inglese in Cina, è al suo primo romanzo e ha scelto di concentrare il focus su due personaggi: una donna ‘cinese’, ma dalle radici etniche complicate che la rendevano già in ‘patria’ parte di una minoranza perseguitata dal regime e un reduce dell’Iraq, che torna in America, alla ricerca di una (ormai impossibile) vita decente, un soldato americano proveniente da un orribile teatro di guerra dal quale è stato traumatizzato, incapace ad un riadattamento sociale di qualunque tipo. Sono loro, quasi esclusivamente, i personaggi dalla prospettiva dei quali il narratore si pone e ci colloca. Sono soli, in modo diverso, le loro vite sono state già ferite, offese, la loro dignità mortificata, per aver subito, lei, le umiliazioni di chi, emigrante, è ridotto a numero, a merce, a carne da sfruttare da parte di un mondo ‘umano’ vissuto come altro, ostile e a cui però bisogna presto adattarsi; e lui, per aver operato in zone di guerra dove il pericolo, l’ostilità e l’incomprensibilità del mondo circostante, unite all’insensatezza di una guerra che uccide e martirizza civili, donne e bambini e che hanno lasciato tracce indelebili nella sua psiche.
Già il cinema americano, ai tempi del Vietnam, aveva trattato il tema dei reduci, ma dopo l’11 settembre ha dovuto ritornare ad affrontare il dramma dei ‘veterani’, i militari lesionati dal proprio stesso vissuto di guerra, nella cui mente vanno in cortocircuito l’immagine patriottica del giovane americano che difende la propria nazione e l’atrocità di una guerra che si manifesta come crimine necessario e inevitabile, come disumanizzazione calcolata di se stessi per poter sopravvivere ad un nemico incerto, confuso, indistinguibile. Film come “Redacted” di De Palma o “Nella valle di Elah” diPaul Haggis (entrambi del 2007) o il recente American Sniper di Clint Eastwood, hanno già provato a smuovere la coscienza americana dal torpore del consueto patriottismo autogiustificatorio, magari per sottolineare lo spessore dei guasti, fisici e morali, che quella guerra, così condotta, produce in quegli stessi soldati e per riflesso nella loro dimensione sociale più prossima, la famiglia per prima.
Lo scenario in cui è ambientato il romanzo è New York, forse la città più ‘globale’ degli Stati Uniti, la più multietnica, certamente la più simbolica. Questa New York è quella fredda e minacciosa dei quartieri poveri e multietnici, in cui le pareti delle case sono sbrecciate, i vetri rotti e le strade e i marciapiedi sono cosparsi di rifiuti svolazzanti, di plastica e mozziconi disseminati fin dentro l’anima. Un non-luogo vero (non quello delle sofisticate teorie sociologiche), perchè ostile, diffidente e inospitale; in cui il McDonald è quanto di più familiare possa capitarti. Sono posti che ti scartavetrano l’anima, che te la riducono una esile poltiglia di ricordi sopravvissuti alla delusione e al fallimento, ‘luoghi’ abitati da persone qualunque, anonime, spesso sole, il cui percorso di vita, di cui nessuno farà un romanzo, ha reso impermeabili ai sentimenti, alla pietà. Sembra un teatro di guerra silenzioso e quotidiano, una schermaglia di cinismi e di sopraffazioni: dietro ogni persona può allignare un abuso, una violenza, uno stupro. Questo vale soprattutto per la donna, una straniera, una reietta, sopravvissuta al viaggio, alla prigione, allo sfrutamento da parte di gente senza scrupoli. La babele linguistica è il terreno raddoppiato di una guerra implacabile: ci si batte per un documento, per un pezzo di carta anche falso purchè eviti il carcere e l’espulsione sempre in agguato. Cos’altro è la guerra se non assenza di pace. Quale pace può esserci nella mente di un reduce da una ‘campagna’ in Iraq? Nulla va via mai dalla mente, da se stessi; tutto è incollato al proprio corpo come l’enorme cicatrice sulla schiena, come la sensazione ancora viva, sulla propria divisa, sulla propria pelle, della carne e della materia cerebrale di un commiltone, che ti è esploso affianco.
Per lei la memoria, più dolce, ma perduta malinconicamente troppo indietro nel tempo, è quella di un mondo infantile, di ‘tenera’ povertà, nel quale, ancora per poco, innocenza e ingenuità prevalgono, e l’assenza di un padre soldato diventa il paradigma di una solitudine e di un’attesa che dureranno per sempre. Poi la memoria è sommersa da schegge mnestiche di paura, di sofferenza, di fatica insopportabile: le marce a piedi, i tragitti dentro furgoni sovraffollati di disperati, la prigione, senza neanche un nome nè un affetto. Il racconto stesso si nutre di questa dispersione di questa frammentarietà, quasi a riprodurre il dolore narrato, il dolore incistato in una psiche turbata ma tenace, colpita ma non affondata. Sul piano della scelta narrativa va sottolineato come in un mondo di squallore e disumanità diffusi, questo personaggio femminile, la donna sola, emigrata da un altro mondo, senza nient’altro che se stessa, non abbandoni mai la speranza di farcela, ostinatamente aggrappata alle proprie risorse fisiche, alle proprie capacità di lavoratrice e all’empatia verso chi, fra i propri simili, le appare ugualmente sperduto, come il reduce. Il veterano che la società non vuole e non sa riaccogliere, i cui legami si sono sfilacciati e disoolti, la cui psiche è malata, cui nessun sonno più e lieve e che ha come unici compagni di vita l’alcol, il fumo e gli psicofarmaci. Che queste due vite si incontrino è il destino del libro, lo si è capito, ma lasciate perdere la dicitura affissa sulla copertina dell’edizione italiana (ma ripresa da una recensione del New York Times) che recita “La storia d’amore più delicata e meno sentimentale dell’ultimo decennio”. Veramente qui di sentimentalismo non c’è traccia, ma forse anche la definizione di amore, andrebbe ridefinita, come se le condizioni di vita dell’oggi, di questo mondo ormai disumano, ci costringessero a ripensare i termini dell’amore oggi. Qui piuttosto due vite si aggrappano, artigliano l’esistenza all’intorno, per lo più respirando diffidenza e cattiveria e trovando nell’altro solo un piccolo intervallo di pace.
Passato e presente si mescolano, come in un loop di cicatrici, fisiche e mentali. Lo stile è teso a raccontarci questo. Siamo lontani anni luce da quelle vite srotolate come un nastro e poi riavvolte dal romanziere, a mostrarci una biografia completata, sensata, persino pedagogicamente appropriata: il montaggio è difficile, schizzato, a volte schizoide (senza purtuttavia che si rinunci mai al racconto), come le figure opache che attraversano le strade dei due protagonisti; la scrittura è singhiozzante ma tesa a scolpire scene di bruttura, come certe sequenze cinematografiche dei noir contemporanei; a volte dipinge con pietà il mondo interiore dei personaggi; oppure lo smarrimento, la fragilità o lo squallore di persone e situazioni.
Pure, ci troviamo di fronte a un racconto ‘umanistico’: c’è una grande compassione nell’ordito complessivo della trama. Anche quando si narra di vite corrotte, malvage persino, è come se l’autore volesse rimarcare la dignità degli esseri la cui stessa vita può essere riscattata da uno sguardo, e che sono come sono forse solo perchè hanno obbedito alle regole implicite di una società spietata e che pretende dai suoi membri la stessa spietatezza.
E’come se Atticus Lish volesse mobilitare il lettore alla comprensione empatica di quelle figure. Non a caso si è detto, e giustamente, che “Preparativi per la prossima vita” è un libro politico. E un romanzo necessario. Forse c’è bisogno di un umanesimo nuovo (un post-umanesimo?), altra cosa rispetto a quel bel quadretto rassicurante che l’occidente ha costruito raccontando se stesso a scapito del mondo. Un umanesimo che sopravviva o prevalga rispetto a questo mondo che ci incute paura, che ci ri-connetta a questa umanità brulicante da cui ci sentiamo invasi, di cui non sappiamo niente, e che vogliamo ignorare o scansare. O peggio.
Forse per non avere paura di queste vite bisognerebbe provare a conoscerle. Anche quando sono ‘inventate’ come quelle della letteratura.
Titolo originale: preparation for the next life (U.S.A. 2014)